La biodiversità: guardiamola bene.
In collaborazione con la redazione di KIT - Knowledge Improving Tools
Cosa abbiamo perso con la scomparsa del rinoceronte bianco settentrionale? Cosa succederebbe se le api smettessero di impollinare le nostre piante? Se avessimo sterminato Penicillium chrysogenum (la muffa che produce la penicillina) oggi avremmo gli antibiotici?
Cosa abbiamo perso con la scomparsa del rinoceronte bianco settentrionale? Cosa succederebbe se le api smettessero di impollinare le nostre piante? Se avessimo sterminato Penicillium chrysogenum (la muffa che produce la penicillina) oggi avremmo gli antibiotici?
Tutte le
domande che sono poste sopra riguardano la BIODIVERSITÀ. Per sensibilizzare le
persone su questo tema, il 22 maggio si celebra la Giornata mondiale della biodiversità.
La
biodiversità, pur essendo una osservazione antica, è una parola relativamente
recente. Infatti, il termine compare per la prima volta in un testo del 1968 da
parte dall'ecologo Raymond Dasmann ed è descritto per la prima volta nel 1988
nel libro “Biodiversità” di Edward Wilson, biologo ed evoluzionista americano.
Da allora ci sono state molte definizioni di biodiversità come ad
esempio:
- “Per diversità biologica si intende la variabilità tra gli organismi viventi di tutti gli ambienti; inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, acquatici e marini e i complessi ecologici dei quali essi sono parte. Questo comprende la diversità all'interno delle specie, tra le specie e negli ecosistemi.”
- “Per diversità biologica si intende la variabilità tra gli organismi viventi di tutti gli ambienti; inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, acquatici e marini e i complessi ecologici dei quali essi sono parte. Questo comprende la diversità all'interno delle specie, tra le specie e negli ecosistemi.”
Questa
definizione è stata presa dalla “Convention on biological diversity”, il
trattato internazionale adottato per proteggere la diversità biologica che nel
2018 compie il suo 25° compleanno.
Dalla
definizione è facile capire che la “biodiversità” non è solo un qualcosa che
riguarda ambienti come le foreste, gli oceani, le montagne ecc..., ma che
riguarda anche la diversità all'interno delle specie stesse. Per fare un
esempio: le molte varietà di mele che troviamo al mercato, sono un ottimo
esempio di biodiversità.
Ci sono poi alcuni ambienti particolarmente ricchi in
biodiversità. Basti pensare che le barriere coralline, le foreste tropicali e
gli estuari dei fiumi ospitano da soli, circa la metà degli esseri viventi del
pianeta anche se coprono solo il 6% della superficie terrestre.
Per non
essere dispersivi cerchiamo di limitarci al caso di più facile immaginazione:
gli ecosistemi. Un ecosistema è composto principalmente da due parti: la
componente biotica, cioè la parte vitale come gli animali e le piante) e la
componente abiotica, ovvero terra, sassi, aria, acqua, luce e clima). Queste due componenti instaurano tra
loro un insieme di relazioni che caratterizzano l'ecosistema stesso e lo
portano in una situazione di "equilibrio variabile” che muta e si adatta a
seconda dei rispettivi cambiamenti. Per capirci possiamo immaginare un batterio
che diventa resistente ad una tossina fungina, in modo da poter resistere all'aggressione. Questo crea un equilibrio fra due specie in competizione. Se
il fungo dovesse evolversi sviluppando una tossina diversa, a cui il batterio è
sensibile, si troverebbe nuovamente in vantaggio. A sua volta il batterio
tenterebbe di evolversi nuovamente per sopravvivere. Questo è appunto un (semplicissimo) “equilibrio variabile”.
QUANTO
CONOSCIAMO E QUANTO ABBIAMO PERSO?
La nostra
conoscenza del mondo vivente è assai limitata, ad oggi sono state descritte
quasi 2 milioni di specie viventi. Se globalmente sappiamo relativamente bene
quante siano le specie di mammiferi, uccelli e grandi piante, possiamo avere
solo una vaga idea di quante siano tutte le altre, come insetti,
batteri, ma anche pesci, funghi ecc. Finora, il numero di specie viventi è
stato approssimato sulla base di ipotesi difficilmente convalidabili, e oscilla
tra i 3 e i 100 milioni. Insomma, il campo è in continua evoluzione con stime e
numeri che cambiano ogni anno.
Le vere
grandi frontiere nell'esplorazione dei viventi sono ancora il mare e gli
oceani. Se infatti le acque coprono circa due terzi della superficie terrestre,
noi ne abbiamo esplorato solo il 5 per cento di esse.
A fronte di questa bassa conoscenza risulta quindi difficile anche dire quanto
abbiamo perso. Tuttavia, si cercano di fare delle stime in base alle
osservazioni di quello che conosciamo. L’Indice del pianeta vivente (LPI -
Living Planet Index) è un indicatore che misura lo stato della biodiversità
attraverso i dati su migliaia di specie di vertebrati monitorate in tutto il
mondo e calcola la variazione media dell’abbondanza delle specie nel corso del
tempo. L'LPI può essere paragonato all'indice del mercato azionario, tuttavia,
invece di monitorare l’economia globale, costituisce un importante indicatore
delle condizioni ecologiche del pianeta. Dal 1970 al 2012, l'LPI globale ha
mostrato un calo complessivo del 58% dell’abbondanza delle popolazioni dei
vertebrati. I dati mostrano un calo medio annuo del 2 per cento e non vi è
ancora alcun segno che questo tasso possa diminuire. Per quanto riguarda invece
gli invertebrati, le piante, i batteri ed i funghi, l'LPI è ancora in fase di
evoluzione e non ci sono dati precisi.
QUALI SONO LE
CAUSE?
La
biodiversità può essere messa in pericolo da vari fattori.
Se pensiamo
alla perdita della biodiversità associamo immediatamente grosse epidemie o
catastrofi: la peste che ha sterminato un terzo della popolazione umana europea
oppure la caduta del meteorite che ha portato alla scomparsa dei dinosauri.
Tuttavia, oggi sono l’uomo e le sue attività a minacciare la biodiversità,
attraverso modifiche dirette ed indirette degli habitat. Una delle cause è
l’inquinamento atmosferico, che porta al surriscaldamento globale. Il
surriscaldamento globale a sua volta causa non solo lo scioglimento dei ghiacci
e fenomeni atmosferici sempre più estremi, ma anche il riscaldamento degli
oceani che può provocare, tra le altre cose, l’estinzione di numerose specie
viventi. Inoltre, le variazioni di temperatura possono alterare eventi
stagionali, come la migrazione e la riproduzione. Eventi inquinanti gravi
infine (come lo sversamento di petrolio in mare) possono modificare l’ambiente
rendendolo inadatto alla sopravvivenza degli esseri viventi.
Il concetto
di degrado dell’habitat naturale è in realtà un concetto molto ampio che
riguarda qualunque modifica che vada a diminuire o distruggere le qualità di un
ambiente che consentono l’equilibrio fra le varie specie viventi lì presenti.
Ad esempio per gli habitat di acqua dolce le minacce comuni sono la
frammentazione dei fiumi. Altre cause di degrado sono la cementificazione
selvaggia, il turismo di lusso in habitat delicati ma non protetti e, infine, gli incendi dolosi boschivi.
Chiaramente
vanno considerate anche tutte le forme di sfruttamento intensivo. Tra queste
abbiamo lo sfruttamento diretto, che viene realizzato sia per la sussistenza
che per il commercio (es. pesca a strascico e bracconaggio). Lo sfruttamento
indiretto invece si verifica per azioni deleterie accidentali, come accade per
alcune specie protette catturate involontariamente nella pesca (es. delfini
pescati dalle tonnare).
Infine, c’è
il problema delle specie aliene invasive. Per specie aliena invasiva si intende
una specie (animale o vegetale) in grado di competere con specie autoctone per
lo spazio ed il cibo. Inoltre, può rivelarsi un predatore per le specie native,
o diffondere malattie che non erano precedentemente presenti nell’ambiente.
Esempi delle nostre zone sono le nutrie o gli scoiattoli grigi. Gli esseri
umani possono importare queste specie attraverso l’allevamento o l’acquisto di
animali domestici come i parrocchetti che hanno invaso Parco Sempione a Milano;
ma può favorirne la diffusione anche abbattendo alcune barriere fisiche come
nel caso dell’ingresso di pesci esotici nel mediterraneo attraverso il canale
di Suez.
MA A COSA SERVE LA BIODIVERSITÀ?
Per capire a
cosa serve la biodiversità dobbiamo introdurre il concetto di servizi degli
ecosistemi.
L’uomo dagli
ecosistemi ricava dei prodotti e dei vantaggi. Questi sono detti, appunto, servizi. Si dividono principalmente in quattro grandi categorie di benefici:
- produzione di beni
che l’uomo può utilizzare come cibo, acqua, materie prime (legno e cibo ad
esempio);
- regolazione dei
cicli naturali come quello del clima o della geologia del pianeta
(pensiamo alla produzione di ossigeno da parte delle piante);
- funzione di supporto
alle sue attività come il ciclo dei nutrienti o l’impollinazione (come la
degradazione di piante o animali morti da parte dei funghi o l’attività di
impollinazione delle api);
- benefici culturali e guadagno in salute, più soggettivi e difficili da calcolare, come smaltire lo stress nel silenzio di un bosco o rilassare i muscoli alle terme.
Spesso questi
concetti sembrano eterei, distanti da noi e addirittura lontani nel tempo.
Cerchiamo allora di capire come la perdita di biodiversità può toccarci
direttamente.
Oltre un terzo degli alimenti umani, dai frutti ai
semi ai vegetali, verrebbe meno se sparissero gli animali impollinatori: api,
vespe, farfalle, mosche, ma anche uccelli e pipistrelli. Questi, trasportano il
polline da un fiore all'altro permettendo la riproduzione delle piante.
Ma allora anche se le api dovessero estinguersi ci
sarebbero sempre le farfalle e le vespe a fare il loro lavoro.
Non è esatto: se per alcune piante l’impollinazione è portata a termine da diverse specie, in
effetti ci sono ben 130 mila piante per cui le api sono essenziali per
l’impollinazione e ciò le rende insostituibili. Ma non parliamo solo di cibo,
parliamo anche di cotone, lana e seta per fare degli esempi. Ma i problemi non
finiscono qui.
Nel momento
in cui un animale dovesse estinguersi, o semplicemente scomparire da un
ecosistema, i suoi predatori potrebbero ridurre drasticamente la loro dieta,
rischiando di morire di fame o viceversa, iniziare a nutrirsi di altri animali
simili. Queste nuove prede avranno un loro ruolo fondamentale nel ciclo vitale,
e la loro decimazione potrebbe causare a catena, danni ad altre piante e/o
animali.
Un altro
esempio classico è quello dei grandi carnivori, come leoni e lupi. Il loro
numero si sta riducendo sempre più negli ultimi decenni a causa della caccia e
delle azioni umane sul loro habitat. La perdita di questi predatori permette
agli erbivori normalmente predati, di crescere in numero senza controllo. Di
conseguenza la vegetazione di quell’ecosistema rischia di subire danni
irreparabili a favore degli erbivori che se ne nutrono.
Questo perché
ogni specie vive in interdipendenza dalle altre e dai servizi che loro gli
forniscono. È una cooperazione basata sulla mutua sopravvivenza, un equilibrio
delicato.
Inoltre biodiversità significa ricchezza genetica. Tante specie che possono
incrociare il proprio patrimonio genetico in favore di una progenie più forte e
magari più utile anche a noi umani.
Si sa infatti che la riproduzione di piante e animali all’interno della
stessa famiglia porta alla lunga all’insorgenza di malattie congenite che
indeboliscono la specie e rischiano di portare a sterilità.
In passato, le risorse genetiche
hanno permesso il miglioramento delle specie coltivate e allevate. Mantenere
tale variabilità, consentirà di ottenere nuove varietà di vegetali da coltivare
o animali da allevare e di adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche e
ambientali. Altre piante invece potranno essere studiate e utilizzate come
fonte di nuovi farmaci naturali per curare malattie dalla prognosi ancora
infausta. Quasi la metà dei farmaci (per un valore
di centinaia di miliardi di dollari) deriva da composti chimici inizialmente
identificati nelle piante. Si calcola che potrebbero essere 70 mila le specie
di piante utilizzate per scopi medicinali, cosmetici e officinali. Attualmente il
mercato mondiale dei farmaci vale più di 600 miliardi di dollari e quasi la
metà si basa su farmaci tratti, direttamente o indirettamente, dai regni
vegetale e animale. Oltre ai derivati sintetici, vi è oggi in tutto il mondo
anche una crescente domanda di rimedi tradizionali e di farmaci di origine
naturale (quelli che di solito si comprano nelle erboristerie). Circa un terzo
delle 3 mila piante utilizzate a questo scopo, viene coltivato appositamente ma
il resto è raccolto in natura, una natura sempre più impoverita dallo
sfruttamento eccessivo dell’habitat. Gli esempi più famosi sono quelli
dell’olio di palma in Indonesia e dell’avocado in SudAmerica.
Inoltre, i cambiamenti climatici sempre più incalzanti e sempre più
difficili da contenere potrebbero rapidamente portarci ad una crisi alimentare
(e non solo). Questa crisi potrebbe essere ritardata o contenuta se la
variabilità genetica degli ecosistemi venisse mantenuta. In questo
modo si manterrebbero alte le probabilità della comparsa di nuove specie capaci
di adattarsi ai cambiamenti climatici, come le elevate temperature d’estate e
le ghiacciate fuori stagione.
Come sta
cambiando il nostro pianeta? Temperature estremizzate sia in estate che in
inverno, precipitazioni più rare che esplodono in alluvioni, ghiacciai in
continuo disgelo con conseguente innalzamento del livello dei mari, aumento
dell’intensità e della frequenza degli eventi meteorologici estremi. Questi
cambiamenti climatici ovviamente, influiscono sulle specie viventi in molti
modi: riproduzione, migrazione e letargo sono anticipati o ritardati in seguito
all'alterazione dei cicli stagionali; le specie modificano la loro
distribuzione geografica (in genere verso nord e ad altitudini più elevate) a
causa dello spostamento delle aree con condizioni climatiche favorevoli; gli
eventi meteorologici estremi (ad es. temporali violenti, estati torride e
siccità) provocano la scomparsa di animali, le inondazioni e la
mancanza di cibo. Il motivo di tutto ciò è abbastanza intuitivo se pensiamo che
sono le condizioni climatiche, insieme ad altri fattori, a determinare le
specie vegetali e animali che possono vivere, crescere e riprodursi in una
determinata regione geografica.
I vantaggi della biodiversità sono tanti. Per dirne un paio: le zone umide come laghi e lagune possono assorbire le
inondazioni; gli alberi sono in grado di stabilizzare i pendii montuosi e gli
argini dei canali.
La biodiversità insomma, garantisce l’adattabilità e un ecosistema in
salute favorisce il recupero dai disastri ambientali.
Ma cosa significa ambiente in salute? Come abbiamo già detto, con la
perdita di una specie l’ecosistema diventa “meno complesso” e si instaurano
eventi a cascata che lo indeboliscono ulteriormente e che possono portare a
danni permanenti. Gli ecosistemi troppo semplici diventano inoltre meno
resilienti, il che comporta una minore capacità di recupero dagli shock.
Quindi, un ecosistema è in salute quando si preserva la biodiversità. Le specie
crescono interconnesse tra loro, in maniera controllata, fornendo supporto
l’una all’altra, anche in caso di eventi avversi.
Beh ma se il problema è la scomparsa di una specie non possiamo
reintrodurla da un altro ecosistema?
Ancora una volta non è esatto. Tecnicamente è possibile sì, e viene fatto
spesso nel tentativo di limitare i danni già causati dall'uomo. Ma non sempre è
possibile e anche se possibile, non è detto che funzioni. Un esempio ne è la
reintroduzione degli orsi in Trentino che, come abbiamo visto l’estate scorsa, ha riscosso qualche problema.
Talvolta infatti, ciò che l’uomo va a modificare in un ecosistema, per suo
profitto o per cercare di porre rimedio ad un danno già causato, finisce per
ritorcerglisi contro. Un esempio famoso è quello dei pescatori che inneggiarono
alla caccia alle balene, colpevoli secondo loro di limitare la quantità di
pesce disponibile per la pesca. La caccia alle balene portò presto le orche, le
loro naturali predatrici, a nutrirsi prima di foche e poi di lontre. Questa
decimazione a catena culminò con la proliferazione incontrollata dei ricci di
mare (non più predati dalle lontre) voraci consumatori di larve di pesce.
L’effetto finale fu un drastico azzeramento dei pesci disponibili per la pesca.
Un effetto completamente opposto alle intenzioni iniziali dei pescatori.
Ma per giocare in casa potremmo fare molti altri esempi. Si potrebbe
parlare dei danni apportati dall’introduzione, volontaria o meno, di specie
dette “aliene”. Queste sono specie non appartenenti al nostro ecosistema e
dunque senza predatori naturali che possano contenerne la crescita e la
diffusione. Due esempi recenti sono l’arrivo della cimice asiatica nei frutteti
e la Xylella fastidiosa negli oliveti. La prima è un parassita che punge e succhia i frutti di oltre
trecento specie botaniche tra cui olivo, vite, peschi, albicocchi, meli
e peri. Dove arriva il suo pungiglione il prodotto cessa di svilupparsi
azzerando il raccolto di tutto l’anno. La Xylella invece, è un batterio
arrivato in Italia nel 2008, che si insinua
nelle vie del tronco in cui scorre la linfa degli ulivi, e ne interrompe il
flusso. Questo “affama” l’albero fino alla sua inesorabile morte. Questo
disastro sta mettendo in ginocchio tutta l’industria dell’olio del Salento, per
il quale siamo famosi in tutto il mondo.
Se i disastrosi effetti a catena non vi sembrassero sufficientemente
“tangibili”, possiamo guardare tutta la situazione dal punto di vista
economico. Sicuramente proteggere gli ecosistemi e la loro biodiversità costa
significativamente meno di riparare ai danni inferti dall’uomo. Ad esempio in
Vietnam, la tutela di 12 mila ettari di mangrovie è costata un milione di
dollari ma ha risparmiato oltre 7 milioni di spese annuali per la costruzione
di argini artificiali e opere di bonifica e ricostruzione a seguito delle
inondazioni annuali. Questo perché nei climi tropicali, barriere coralline e mangrovie aiutano a proteggere le
coste dai danni provocati dalle tempeste.
Talvolta invece si pensa di essere
sulla strada giusta, ma non è proprio così. Grosse multinazionali utilizzano
estensivamente i boschi per produrre legname e cercano di rimediare piantando
nuovi alberi. Parlano dunque di economia sostenibile, ma sostenibile per chi?
Di fatto gli alberi piantati sono specie a crescita rapida, utili per un nuovo
ciclo di disboscamento/semina, che però utilizzano grosse quantità di acqua.
Questo va ad impoverire i terreni ed indebolisce le barriere naturali come è
successo in Bangladesh, dove questo tipo di sfruttamento delle riserve boschive
ha portato a tragici effetti all'arrivo delle stagioni dei monsoni.
Insomma, il detto rimane vero sempre. Prevenire è meglio che curare.
QUINDI COSA POSSIAMO FARE PER PREVENIRNE LA PERDITA?
Mantenere la
biodiversità è un dovere e una possibilità di tutti noi. Per farlo prima di
tutto è necessario esserne consapevoli: bisogna informarsi sui luoghi dove si
va e sui comportamenti da tenere. La conservazione dell’ambiente è il primo
punto: evitare di inquinare, tenere comportamenti civili e rispettosi (ad
esempio fare fuoco dove è consentito e spegnerlo adeguatamente, non raccogliere
fiori o funghi dove è vietato), ma anche attività quotidiane, dal risparmio
energetico a comprare marchi o cibi che provengono dai metodi più sostenibili a
livello ambientale (ad esempio frutta di stagione o locale oppure accertarsi
della metodologia di pesca). Altre attività sono evitare uccisione di animali
selvatici per paura o ignoranza: un esempio eclatante è l’uccisione ogni
primavera di serpenti o non (ad esempio orbettini) scambiati per vipere; in
questo caso è un reato (legge 150/1992) in quanto i rettili sono considerati
animali protetti e bisognerebbe (nel caso in cui si avvistasse un rettile
considerato potenzialmente pericoloso) avvisare i carabinieri forestali o la
ASL territoriale che ne accerterà l’effettiva pericolosità ed eventualmente ne
gestirà la cattura. In ogni caso ricordatevi che hanno più paura loro di
voi che voi di loro e prima di mordere preferiscono scappare.
Educazione
e conoscenza sono le armi fondamentali per mantenere e proteggere la
biodiversità!


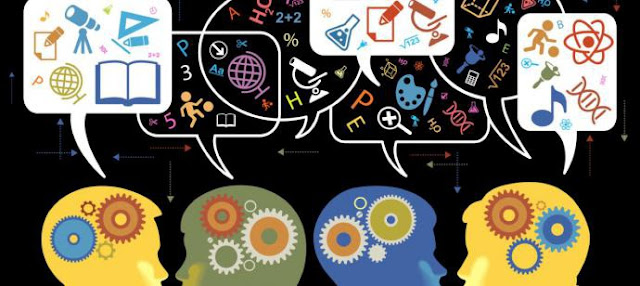
Commenti
Posta un commento