Razze e razzismo: parliamone... scientificamente!
Nel 1918 sul
Piave ha combattuto quella che viene chiamata la “Razza Piave”; quando una
persona è spregevole talvolta si dice che è “di una cattiva razza”; al Sud
capita di sentire parlare dei nostri vicini Greci citando il motto che abbiamo
in comune “Italiani e greci: una faccia, una razza”; o ancora, una leggenda
(perché tale sembra essere) narra che Einstein, giungendo negli USA nel 1933,
indicò nei documenti di essere di “razza umana”. Questi sono solo alcuni esempi
dell’utilizzo quotidiano del termine razza riferito agli esseri umani.
 Naturalmente
fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e
che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.
Naturalmente
fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e
che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.
Come avrete capito, oggi assieme a KIT - Knowledge Improving Tools parliamo delle razze.
Ma cos'è una
razza?
In biologia,
la razza classifica e divide gli individui, animali e piante, di una medesima
specie in base a caratteristiche comuni e facilmente evidenziabili. Ma va
subito precisato che questa “classificazione” non identifica un'unità tassonomica vera e propria
(come “specie”, “genere”, “famiglia”, ecc.), bensì un gruppo di individui afferente
a una determinata specie, di cui però fanno parte anche altre razze.
Per fare un
esempio possiamo parlare delle razze canine. Ciascuno di noi è in grado di
distinguere a colpo d’occhio un Carlino da un Alano. Questa nostra capacità di
distinguere cani di razza diversa ha dei fondamenti biologici spesso molto
evidenti. Benché siano interfecondi (possono riprodursi tra loro) e
appartengano, quindi, alla medesima specie, un Carlino è geneticamente differente
da un Alano.
In gergo
tecnico si dice che la variabilità genetica interna all'insieme dei Carlini, è
inferiore alla variabilità genetica media che esiste tra l’insieme dei Carlini
e l’insieme degli Alani. Detta in maniera più semplice ancora: la differenza
del DNA di due Carlini è significativamente minore della differenza genetica media
che c’è tra il DNA dei Carlini e quello degli Alani.
Da dove
nasce il concetto di razza umana?
Partiamo
dalla storia. Il concetto di razza umana è antico, ovvero esiste da quando l’uomo
ha iniziato a domandarsi perché gli uomini al di là del mare fossero così
diversi da lui. Il primo a cercare una spiegazione fu Plinio il Vecchio,
scrittore, filosofo e comandante militare romano, che spiegò la diversità tra
le diverse popolazioni come una conseguenza diretta del clima. Nelle fredde
regione settentrionali, quelle più lontane dal Sole, «le razze hanno pelle
bianca come la neve, con capelli gialli che cadono diritti». Gli africani,
invece, «sono bruciati dal calore del corpo celeste che è loro vicino, e
nascono con un aspetto bruciacchiato, con capelli e barba riccioluti». Chiaro è
che Plinio non poteva conoscere la genetica e le sue regole.
Nonostante ciò, per secoli la convinzione che le differenze morfologiche tra le
popolazioni umane fossero conseguenza di differenze ambientali (clima,
alimentazione, stile di vita…) rimase forte nella cultura e nella scienza. Fu solo
nel XIX secolo che gli scienziati diedero al termine razza la connotazione
razzista che conosciamo oggi.
Come ci
siamo arrivati?
Fu Linneo,
uno dei primi evoluzionisti, a descrivere nel 1735 quattro diverse razze umane.
Ma solo nel 1775, con gli studi di Johann Friedrich Blumenbach, iniziò a
circolare negli ambienti scientifici e culturali la teoria che le razze fossero
separate non solo da fattori estetici, ma anche dalle effettive capacità
fisiche e soprattutto mentali.
Blumenbach sosteneva
che la specie umana fosse una sola, ma distinta in cinque razze: la caucasica,
formata dagli abitanti dell’Europa, dell'Africa settentrionale, del Medio
Oriente e dell'India; la mongolica, formata dagli orientali ma anche da
Finlandesi e Lapponi; la etiopica, formata dalle popolazioni nere dell’Africa
sub-sahariana; l’americana, formata dagli indigeni di quel continente; e infine
la malese, formata dagli abitanti degli arcipelaghi del sud-est asiatico e
della parte dell’Oceania allora conosciuta.
La convinzione
su cui Blumenbach basava la sua teoria era che l’uomo fosse nato nel Caucaso e
che tutte le altre razze fossero il frutto di un processo degenerativo. Altri
studi spinsero in questa direzione fino a sfociare nella cosiddetta “scala
delle razze”.
Ma ad oggi, sappiamo che questi studi erano basati su metodi
antropometrici inconsistenti, come la misura della dimensione del cranio,
l’altezza, lo studio della forma dell'arcata sopraciliare e tanti altri
parametri proposti ad hoc per
avvalorare le tesi proposte.
Bisogna
aspettare il 1859 e la pubblicazione de “L’origine delle specie” di Charles
Darwin, perché questa teoria venga messa in discussione. Darwin scrisse che le
specie viventi, compresa quella umana, non sono entità statiche, ma si
modificano nel tempo ed evolvono adattandosi ai cambiamenti dell’ambiente. Questo
comporta che non esistano razze migliori di altre, ma solo individui più o meno
adatti a sopravvivere in un determinato habitat che muta nel tempo. Lo stesso
Darwin, nel 1871 però, si corresse pubblicando “L’origine dell’uomo”, dove invece
sosteneva che ciascuna razza umana «confluisce gradualmente nell'altra» e che proprio
per questo siano quindi completamente interfeconde. Aggiunse poi che, nonostante
talvolta le differenze appaiano vistose, in termini biologici sono del tutto
irrilevanti.
Spiegare
quest’ultimo concetto non è semplicissimo, ma arriviamoci per gradi.
Il sistema
evoluzionistico proposto da Darwin venne sfruttato nel ‘900 a favore delle
teorie razziste. Infatti, Darwin stesso nei suoi libri dichiarava che le
differenze fra le popolazioni erano dovute ad una selezione naturale di tipo sessuale,
cioè erano dovute al fatto che certi individui, in certe aree, risultassero più
fecondi di altri. Questa sua ipotesi fu usata (mal interpretandola) da altri come
punto di partenza, assieme agli studi prodotti dalla comunità scientifica tra il
‘700 e gli inizi dell’800, per giustificare che ci fossero razze “migliori” di
altre. Il culmine di queste correnti di pensiero si ebbe tra gli anni ‘30 e ’60
del ‘900 con gli infausti eventi del genocidio razziale Nazista in Europa e
dell’Apartheid in Sudafrica.
Il primo
tentativo di porre fine alla distinzione degli esseri umani in razze, si ebbe
nel 1962 quando Frank B. Livingstone pubblicò l'articolo “On the Non-Existence
of Human Races”. In questo scritto, Livingstone afferma che la variabilità
biologica umana non è “impacchettabile” nel termine razze, tuttavia il
dibattito rimase ancora aperto nel mondo scientifico.
Con
l'aumento della conoscenza del DNA e della biologia molecolare della fine del
XX secolo, si è cercato di mettere nel cassetto il termine razza. Le
popolazioni, anche le più geneticamente distanti infatti, sono risultate avere
tutte in comune il 99,9% del DNA. Le
differenze macroscopiche che osserviamo oggi come il colore della pelle, dei
capelli e degli occhi, o la capacità di digerire il lattosio, vanno ricercate in quel misero 0,1% di differenze nel genoma.
Esistono
varianti uniche di certe popolazioni? Certo, ma sono trascurabili.
Per esempio,
di quello 0,1% di differenze genetiche riscontrabili confrontando due
popolazioni a caso, solo un 7% è esclusivo delle popolazioni africane. Ovvero una
popolazione africana differisce dalle altre popolazioni solo per lo 0,07% del
DNA. E stiamo parlando di una delle popolazioni con più variabilità genetica. Gli
asiatici ad esempio differiscono molto meno dagli europei.
Il motivo di
questa differenza tra le popolazioni africane e quelle del resto del mondo, sono
i fenomeni migratori che hanno portato l’uomo ad uscire dall'Africa. Si tratta, semplificando, di quello che in ecologia viene detto “effetto del fondatore”.
In
pratica, la teoria più accreditata su questo tema dice che 70.000
anni fa, una piccola popolazione nordafricana è uscita dal continente colonizzando
la Palestina e la Mesopotamia. Da lì poi questa popolazione si è espansa in
tutto il resto del mondo, dividendosi in gruppi sempre più piccoli e limitando
così, la variabilità genica delle nuove popolazioni. Questo processo evolutivo
ha determinato una perdita della variabilità genetica delle nuove popolazioni,
che di fatto tra loro rimangono pressoché uguali, mentre differiscono
maggiormente dalla popolazione originaria africana.
Immaginate di avere un barile con
migliaia di palline da ping-pong di 20 colori diversi. Questo barile si chiama “Africa”.
Pescando cento palline a caso da mettere in un secchio, che chiamiamo “Medio Oriente”,
ci ritroviamo con palline di soli 10 colori diversi. Poi da questo secchio ne
peschiamo altre cinquanta di palline, per riempire la ciotola dal nome “Europa”.
Queste cinquanta palline risultano di 8 colori diversi. Se confrontate barile,
secchio e ciotola tra loro, noterete che in Europa mancano solo due colori che
invece sono presenti in Medio Oriente; mentre ne mancano ben 12 di quelli
presenti in Africa.
Ecco, va
detto che la genetica delle popolazioni è ben più complicata di così, perché si
occupa di miliardi di geni (non solo una ventina…) e perché dipende anche da
fenomeni selettivi naturali, migrazioni, incroci ecc. Però ora vi siete fatti
un’idea (si spera ndr) del perché alcune popolazioni abbiano maggior
variabilità genica al loro interno, rispetto ad altre.
 Naturalmente
fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e
che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.
Naturalmente
fino ad ora abbiamo parlato dell’Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo e
che sembra essere nata nell'odierna Etiopia.
L’Homo sapiens si è
diffuso rapidamente nel mondo nel giro di 20-30 mila anni. Pensate che si diffuse
così rapidamente, che i primi abitanti dell’attuale Inghilterra furono di pelle
nera, mentre le mutazioni che hanno portato a schiarire la pelle, i capelli
ecc. si sono sviluppate solo più tardi.
Diamo anche
qui qualche indicazione storica. Dalle prove fossili, pare che i primi sapiens dell’Africa avessero la pelle
chiara, che per fenomeni di selezione naturale diventarono sempre più rari
favorendo gli individui di pelle scura. La pelle chiara è probabilmente ricomparsa
come dominante circa 7.000 anni fa, nell'attuale Turchia e Asia centrale.
I primi
europei, giunti 40.000 anni fa circa, erano anch'essi di pelle scura. A
dimostrarlo sono le prove fossili molto ben conservate del “Cheddar man”, lo
scheletro di un uomo di 10.000 anni fa scovato in Inghilterra. La genetica di
questo fossile ci ha dimostrato come all'epoca, in Inghilterra ci fossero
uomini di pelle scura ma occhi azzurri. Inoltre, altri ritrovamenti in Spagna,
Svizzera e Lussemburgo hanno confermato questa scoperta.
Le migrazioni,
quindi, sono state e sono tutt'oggi il motivo per cui gli esseri umani non
possono essere suddivisi in razze, che di fatto non esistono. Se in Europa attualmente
prevalgono le persone con pelle bianca, è solo perché 7.000 anni fa circa ci
furono grosse migrazioni provenienti dalla Turchia e dall'Asia centrale che
importarono questa mutazione. Ciò non esclude per altro, che fra qualche
migliaio di anni la popolazione europea non possa tornare ad avere la pelle ed
i capelli neri.
Tornando
quindi a ciò che scrisse Darwin nel libro “L’origine dell’uomo” (ciascuna razza
umana «confluisce gradualmente nell'altra»), possiamo interpretare le sue
parole dicendo che ogni popolazione non
è altro che una sfumatura di quella che le sta vicina.
Le
popolazioni di tutto il pianeta si sono mescolate tra loro per millenni (anche
se alcune di più e altre di meno), mixando di conseguenza anche il proprio
genoma. Sebbene ci siano comunque alcune caratteristiche che rimangono tipiche
di alcuni continenti e aree geografiche, queste fanno parte di quel misero 0,1%
di cui abbiamo parlato poco fa. Di conseguenza il risultato finale possiamo
esemplificarlo così:
tra una popolazione A e una B, la
differenza è data da pochissimi alleli (es. 1,2 e 3); mentre la popolazione B differisce
dalla C per altri tre alleli (es. 4,5 e 6). Anche se la popolazione A
differisce dalla C per altri tre alleli (es.7,8 e 9) magari queste due
popolazioni possono condividere gli alleli per altri geni che ne A ne C hanno
in comune con la popolazione B (es. 1, 3 e 6).
Quindi, la
distanza tra una popolazione e l’altra è visibile solo se si confrontano le
popolazioni a due a due. Confrontando tutti i popoli contemporaneamente è evidente
come queste divergenze siano irrisorie e soprattutto siano insufficienti per
delineare gruppi di individui (razze) dai confini e dalle caratteristiche ben
delineati.
Ma al di là delle
motivazioni scientifiche, anche l’analisi dell’etimologia della parola,
giustifica il fatto che sia un errore suddividere gli esseri umani in razze.
La parola razza è una
traduzione medievale del termine in francese antico haraz che significava “allevamento di cavalli, mandria, branco”.
Questa parola serviva a identificare tutte quelle specie animali o vegetali che
venivano selezionate dall'uomo, in base alle loro caratteristiche biologiche
che fornivano caratteristiche migliori.
Togliere le
fondamenta scientifiche dal concetto di razza umana, purtroppo non è
sufficiente ad eliminare il razzismo, un fenomeno che invece persiste sul piano
culturale. Ma anche in questo caso la scienza potrebbe tornarci utile.
Infatti,
possiamo chiederci: non potrebbe essere il razzismo ad avere invece un
fondamento biologico?
Da qualche
decennio gli scienziati hanno capito che guardare al nostro passato evolutivo
può aiutarci a capire non solo come siamo fatti, ma anche come pensiamo, come
agiamo e come ci comportiamo in rapporto agli altri.
La
rivoluzione agricola, collocata poco più di 10.000 anni fa, segnò il passaggio
da una condizione nomade a una stanziale. Fino ad allora i nostri antenati
vivevano in piccoli gruppi che si spostavano costantemente per procacciarsi le
risorse necessarie al proprio sostentamento. Con la formazione di piccoli raggruppamenti
stanziali, prese piede una strategia di sopravvivenza che possiamo denominare “parrocchialismo”.
In sostanza i soggetti erano altruisti con gli individui che conoscevano e con
cui avevano familiarità, mentre non lo erano, o lo erano molto meno, con chi non
riconoscevano come parte del proprio gruppo e con cui di conseguenza erano in
competizione per la sopravvivenza. Uno studio neuroscientifico pubblicato su
Nature Neuroscience nel 2012, intitolato “The neuroscience of race”, ha
mostrano che anche il cervello di chi ai giorni nostri dichiara di non avere
pregiudizi di sorta, mostra preferenze per immagini di individui ritenuti più
familiari. In queste condizioni si attiva infatti un circuito neurale che coinvolge
le aree del cervello che regolano le emozioni (come ad esempio l'amigdala) e le
capacità di prendere decisioni. Si tratterebbe dunque di una preferenza innata
e di origine evolutiva.
Questo
significa che siamo quindi condannati ad essere razzisti?
Non deve
essere per forza così, poiché l’evoluzione cognitiva è solitamente molto più
rapida di quella biologica. Una opportuna educazione e un adeguamento del
contesto sociale potrebbero essere sufficienti a cambiare rapidamente le
dinamiche sociali, eliminando una classificazione umana che dal punto di vista
scientifico abbiamo visto non esistere.
PS: questo post è dedicato con la mente e col cuore al defunto Luigi Cavalli Sforza, grande genetista italiano che ha contribuito a smontare scientificamente il concetto di razza.
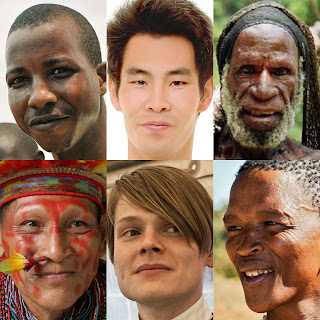


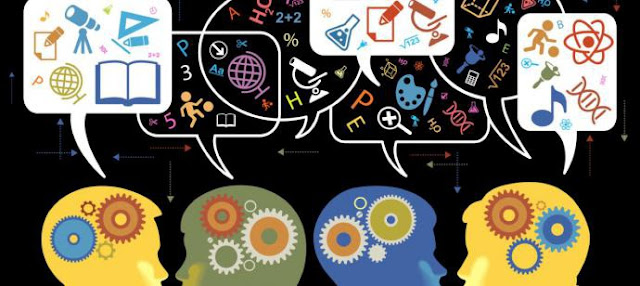
Commenti
Posta un commento